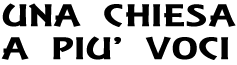XXIX DOMENICA ANNO A con preghiera dei piccoli
Dal vangelo secondo Matteo 22, 15 - 21
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
A prima vista il passo del Vangelo che ci viene proposto per la preghiera di questa domenica si presenta come una riflessione su questioni fiscali o una proposta di soluzione per il delicato equilibrio tra poteri diversi (religioso e temporale). In realtà la risposta di Gesù a chi sta tentando di coglierlo in fallo (!), ci presenta una precisa visione dell’uomo carica di saggezza e con al suo interno la forza di liberare ogni uomo da qualsiasi schiavitù, sottomissione o oppressione.
Partiamo dalla domanda che viene posta a Gesù. Se Gesù avesse risposto “Sì, è lecito” (pagare il tributo a Cesare), sarebbe apparso come un “collaborazionista” dei Romani, deludendo tutte le aspettative dei movimenti profetici e politici incentrati sull’indipendenza. Se Gesù avesse risposto: “No”, sarebbe stato immediatamente accusato di ribellione, presentato come sovversivo, come rivoluzionario. Gesù sa molto bene che chi gli rivolge la parola sta tentando di incastrarlo, che il colloquio proposto è, in realtà, un tranello.
Gesù si fa portare una moneta e, con il denaro in mano, domanda di chi sono l’immagine e l’iscrizione impressi sopra il “metallo”. “Di Cesare” è la risposta. Prosegue Gesù: “Restituite dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Ciò che è di Cesare è chiaro: la moneta. Non solo: ciò che è raffigurato sulla moneta (l’immagine) e ciò che sopra il denaro è scritto (iscrizione) rappresentano il diritto dell’Imperatore a possedere (a dominare) quel denaro perché di sua proprietà. Ora, la forza dell’argomentare di Gesù è rappresentata proprio da questo esempio. Come l’immagine sulla moneta rimanda all’imperatore, così deve esserci un’altra realtà che porta su di sé l’Immagine e l’Iscrizione che esprimono i diritti di Dio. Il passaggio ora è trasparente. L’immagine vivente di Dio è l’uomo (creato a sua immagine e somiglianza – Genesi 1,27), la persona. Ed è l’uomo che porta nel cuore “scritta” la legge di Dio (Geremia 31,33).
La sintesi costruita sull’espressione “immagine e iscrizione” svela ora tutta la sua forza e chiarisce il senso del restituire a Cesare e a Dio. Le monete che appartengono a Cesare vengano riportate al suo legittimo proprietario. Ma proprio perché il ragionamento è lineare, si provveda anche a “restituire” ogni persona a Dio che ci ha creati liberi e a Sua immagine e somiglianza. E si noti che “restituite a Dio quel che è di Dio” significa non solo “Restituite l’uomo a Dio”, ma anche (e soprattutto) “Restituite l’uomo all’uomo”. Dio non crea per possedere e per rendere schiavi. Dio ci ha creati per affidarci alla libertà. Tutto ciò che calpesta la dignità dell’uomo e ferisce la sua libertà deve essere – di conseguenza – fermato perché si possa restituire – a Dio e all’uomo – la piena dignità di ogni creatura umana. Gesù non annulla il profondo legame che tiene insieme Creatore e creatura. Ci
ricorda però che Dio ha creato per amore e, proprio per questo, non possiede, non consuma, non schiaccia la persona, ma propone - per l’essere umano e per ogni persona - autonomia e libertà. Così riletto il Vangelo di questa Domenica diventa di sconcertante attualità.
Soprattutto se pensiamo a quanti sono segretati, umiliati, offesi, feriti e imprigionati (nel vero senso della parola) dalle tante, troppe guerre che ci circondano. Se pensiamo a quanti sono incatenati dall’odio che lega gli uni contro gli altri. Il terrorismo di Hamas ha ucciso, sequestrato e trucidato donne e bambini israeliani. Senza pietà e oltrepassando qualsiasi limite imposto da qualsiasi guerra. La reazione di Israele nel segno della legittima difesa si sta addentrando sui sentieri della vendetta e nega cibo, viveri, acqua, carburante ed energia elettrica a quanti sono imprigionati in una “striscia di terra” senza possibilità di difesa e di sopravvivenza. Nel chiuso delle trincee ucraine la situazione non è molto diversa. E a Putin che chiede il cessate il fuoco a Israele viene da domandargli perché quell’invito non lo rivolge anche al suo esercito impegnato in una spregiudicata e ingiusta operazione di occupazione militari di territori che non gli appartengono.
Mai come oggi abbiamo bisogno che risuoni nel mondo l’invito di Gesù a restituire l’uomo – ogni persona - al Dio della Pace e dunque che ad ogni uomo venga restituita la sua dignità, la sua libertà e la sua possibilità di vivere nella pace. Abbiamo bisogno che si zittiscano le armi e che cessino le guerre. Mai come oggi abbiamo bisogno che i bambini vengano restituiti alle loro famiglie, alla scuola, alle cure ordinarie in contesto sanitario, al gioco, ai cortili e alle piazze.
E se i soldi vengono investiti, spesi e sprecati per costruire armi (nel 2022 si sono spesi 100 miliardi di dollari in più rispetto al 2021 raggiungendo i 2.240 miliardi di dollari investiti, in un solo anno, in armi e munizioni) è segno che la parola di Gesù ha qualcosa da dire anche ai nostri Governanti: non usate il denaro per “dominare” il mondo, ma per restituire l’uomo all’uomo e per liberare l’essere umano dalla fame, dalla siccità, dai cambiamenti climatici e dalle ingiustizie che opprimono e che uccidono la vita di tanti, troppi fratelli.
Buona domenica.
Preghiera dei piccoli
Caro Gesù,
sono confusa e non capisco più il mondo. Non capisco le guerre; non capisco l’orgoglio, non capisco perché le persone debbano ammazzarsi tra loro, non capisco perché in guerra si debbano uccidere anche i bambini e non capisco perché vengono bombardate anche le case, le scuole, gli ospedali, i giardini, i campi di calcio, etc.
Ho chiesto a mamma di non guardare i telegiornali quando io sono in casa. Quelle scene di morte e di città distrutte mi fanno paura.
Ma non capisco nemmeno perché siano così tanti quelli ti vogliono male e che ti tendono tranelli “per coglierti in fallo nei tuoi discorsi”.
A me piace come parli, come Ti muovi o cosa dici.
Con l’aiuto di una moneta oggi ci hai ricordato che siamo stati creati a Tua “immagine” e somiglianza e che nel nostro cuore c’è “scritta” la legge dell’amore.
Gesù, ti prego, donaci la Pace.